
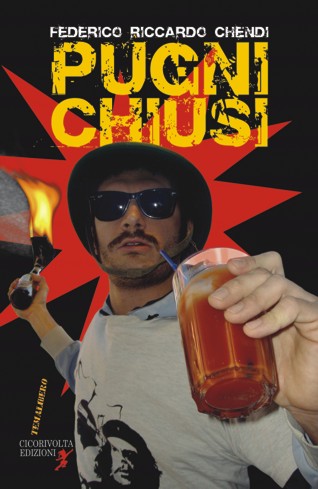
ordinalo senza spese di spedizione
... e di Federico Riccardo Chendi leggi anche VOLEVO ESSERE VALLANZASCA

titolo:
"PUGNI
CHIUSI"
autore Federico Riccardo Chendi
ISBN 978-88- 95106-22-9
€
10,00 - pp.149
- © 2008 in
copertina, foto originale di Daniela Ambrosio
- Elaborazione grafica di
Emidio
Giovannozzi
PUGNI
CHIUSI parla di fuga e di militanza,
tempo di vita e di morte, giustizia e ingiustizia,
vera e presunta rivoluzione.
Molti immaginano le rivoluzioni come una serie di atti eroici, come
battaglie straordinarie, ma esserci dentro è un’altra storia.
C’è solo il fango e il sudore e la paura. Ci sono i giorni
vuoti, passati a fare nulla, e i gesti banali. Ma quando finisce il
combattimento, tutto diventa più nitido, e una sensazione di
vuoto ti avvolge e ti sazia.
Ho deciso io di fare questa vita, non me l’ha imposta nessuna circostanza,
né la povertà, né il caso. Ripercorro ogni bivio
della mia esistenza, la scelta della violenza è stata nel mio
caso dettata soltanto da una insana razionalità. Non vi è
mai stata traccia di velleitario nei miei pensieri e nei miei gesti;
ho sempre nutrito la convinzione che soltanto le battaglie disperate,
inutili, valgano la pena di essere combattute. Quella dell’indipendentismo
corso era soltanto una fra le diverse ipotesi che ho preso in considerazione;
ma io non sarò mai un terrorista, io sono un combattente.
Adesso che sono lontano da Crescenzago, mi manca un poco anche quel
suo caratteristico caos edilizio, quelle sue costruzioni disomogenee,
quella speculazione selvaggia. Non so se rivedrò ancora il mio
quartiere. Davanti a me non c’è più il palazzo con
l’intonaco color giallo-Milano screpolato in più punti,
con le tegole e i balconi coperti di muschio e di sterco di piccioni.
Adesso, se mi affaccio dalla finestra, vedo il mare, il mare odoroso
del porto di Ajaccio.
leggi la recensione di arcilettore
Brano tratto da "PUGNI CHIUSI"
A
ogni incrocio mi voltavo verso piazzale Loreto per vedere se arrivava
l’autobus. Milano era immobile, stranamente silenziosa, avvolta in
una notte scura, senza pioggia. Via Padova odorava di spezie e di asfalto
umido, di sudore e di birra. Quella era la mia zona. Iniziò a piovere
all’improvviso.
Il sapore che avevo in bocca era amaro come il sangue che scorreva mischiato
all’acqua sul marciapiede. Era di un ragazzo della mia età,
la barba appena accennata gli cresceva a macchie sulla pelle olivastra.
Stava a terra. Perdeva del sangue dal naso e dalla bocca. Si lamentava
appena. Non avevo avuto il coraggio di dire una sola parola.
Stavo con i pugni chiusi nell’ombra a vedere quei ragazzi che si
allontanavano. La 56 barrata passò senza fermarsi. La luna scomparve
dietro un palazzo troppo alto. Smisi di respirare per qualche secondo.
Chiamai un’ambulanza e mi incamminai verso casa. Le macchine alzavano
spruzzi che mi bagnavano. Non li sentivo. Provavo soltanto la banalità
del dolore, che non serve a nulla senza la rabbia.
Non è vero che il sangue dei vinti e dei vincitori ha lo stesso
colore. Un tempo lo credevo anche io, ma con il passare degli anni mi
sono dovuto ricredere. Il sangue dei vinti è di un rosso più
intenso, più persistente, insomma è più sangue di
quello dei vincitori. Forse perché morendo ne spargono di più
sull’asfalto, sul cemento, oppure sul cuscino o sul legno di una
scrivania. Non è una differenza che si può apprezzare con
l’ausilio di un microscopio, ma soltanto a occhio nudo. Ci sono uomini
che sanno per cosa lottano, altri soltanto lo sospettano. Ma è
dal contrasto con una superficie bianca che risalta al meglio la vivacità
del rosso del sangue. Solo sulla carta si può senza dubbio distinguere
il sangue di un vinto da quello di un vincitore.
Crescenzago è una zona a nord-est di Milano, un cuneo incassato
fra Sesto San Giovanni, Cologno Monzese e Vimodrone; un triangolo che
ha per lati viale Monza, via Palmanova e la tangenziale est. E’ un
brandello di Milano tagliato in due dal naviglio Martesana e percorso
in tutta la sua lunghezza da via Padova. Oggi è il quartiere più
multietnico d’Italia, una casbah ai bordi di Milano, ma quando questa
storia ha avuto inizio nei suoi cortili si udiva un mix di pugliese, di
calabrese e di brianzolo e non un vociare indistinto di arabo, cinese
e spagnolo. Erano ancora più lontani gli anni in cui la zona era
stata terra di conquista delle diverse bande della ligera, la mala milanese,
che controllavano il quartiere più della polizia. Delle osterie
non c’era più traccia, dove i delinquenti comuni si mischiavano
con gli schedati politici, dove nascevano i colpi e le spedizioni punitive.
Erano gli anni in cui la violenza era violenza e basta, che fosse ideologica
o criminale poco importava, dava rispetto e ammirazione all’interno
del quartiere. Certo era un gioco che durava poco, nei migliore dei casi
portava dritti a San Vittore, più spesso lasciava stesi sul selciato
in una pozza di sangue, ma le regole le sapevano tutti, e le accettavano.
Crescenzago era il mio quartiere, ma non solo. Quando mi svegliavo la
mattina e inforcavo la vespa per andare in un liceo del centro, all’altezza
di piazzale Loreto avevo la stessa sensazione che si prova dopo aver varcato
una frontiera. Dalla finestra della mia camera la vista era desolante,
i caseggiati erano addossati gli uni agli altri senza nessun criterio,
quasi fossero il frutto della malsana creatività di qualche urbanista.
In mezzo a quella distesa di condomini stava la villa liberty della mia
famiglia, costruita da un antenato eclettico quando Milano si fermava
diversi chilometri prima. Con il passare dei decenni la città aveva
raggiunto la nostra villa e aveva proseguito il suo sviluppo sino a congiungersi
con Sesto San Giovanni, poi aveva cercato altrove terreno per espandersi.
Nonostante i miei genitori mi avessero sempre fatto frequentare le migliori
scuole della città e i figli dei loro amici altolocati, la periferia
e la sua gente mi aveva sempre attratto di più.
Giorno dopo giorno Crescenzago e le sue bande diventavano la mia famiglia.
Adesso
che sono lontano da Crescenzago, mi manca un poco anche quel suo caratteristico
caos edilizio, quelle sue costruzioni disomogenee, quella speculazione
selvaggia. Non so se rivedrò ancora il mio quartiere. Davanti a
me non c’è più il palazzo con l’intonaco color
giallo-Milano screpolato in più punti, con le tegole e i balconi
coperti di muschio e di sterco di piccioni. Adesso, se mi affaccio dalla
finestra, vedo il mare, il mare odoroso del porto di Ajaccio. Sono chiuso
in questa casa da due settimane ma non mi sento in trappola, mi sento
libero come non lo sono mai stato prima. Quindici giorni fa ho ucciso
un uomo, e il colore del suo sangue riempie le mie notti, non di incubi,
ma di sogni iperrealisti come i quadri americani, fatti di immagini soltanto
leggermente sfumate sui bordi, che rappresentano i confini di una scelta
che si fa chiara, mentre altrove le pistole tacciono e lasciano il posto
al ticchettio delle dita sulle tastiere dei computer, io ho deciso di
sparare, è stata la prima volta, ma ho l’impressione che non
sarà l’ultima.
Apro la finestra, fuori è una serata scura, che neanche i lampioni
mossi dal vento riescono a illuminare.
Ho finito il pastis e la birra alla castagna, mi rimane soltanto una bottiglia
di vino di Patrimonio; domani sarò costretto a uscire se qualcuno
non mi verrà a rifornire entro sera. Sto imparando la lingua corsa
e mi alleno ascoltando le canzoni tradizionali e parlando da solo. Anche
se sono confinato in due umide stanze non mi sento per nulla incarcerato.
Ho deciso io di fare questa vita, non me l’ha imposta nessuna circostanza,
né la povertà, né il caso. Ripercorro ogni bivio
della mia esistenza, la scelta della violenza è stata nel mio caso
dettata soltanto da una insana razionalità. Non vi è mai
stata traccia di velleitario nei miei pensieri e nei miei gesti; ho sempre
nutrito la convinzione che soltanto le battaglie disperate, inutili, valgano
la pena di essere combattute, queste sono le sole in grado di destare
in me un qualche fascino. Quella dell’indipendentismo corso era soltanto
una fra le diverse ipotesi che ho preso in considerazione. In un primo
momento avevo pensato di aderire alla causa palestinese, sono stato anche
qualche settimana a Gerusalemme e nei territori occupati, ma la situazione
non era favorevole ai miei progetti. I più attivi erano quelli
di Hamas e degli altri gruppi islamisti, e io non volevo aver nulla a
che fare con il fanatismo religioso e con il terrorismo; io non sarò
mai un terrorista, io sono un combattente. Certo ero rimasto affascinato
da Gerusalemme, quella città di pietra bianca che mi attraeva come
una calamita e mi respingeva con il suo esasperante ribollire di conflitti.
Entrando dalla Porta di Damasco venni sommerso da un inestricabile intreccio
di minareti, campanili, sinagoghe. Il suo profilo visto dal Monte degli
Ulivi, che brillava di riflessi dorati sotto la brezza della sera, era
metafisico tanto quanto la sua condizione, crocevia di ogni contraddizione,
porta del paradiso e dell’inferno al contempo, slanciata verso l’altezza
dell’infinito e verso le viscere della terra. Rimasi giorni a camminare
fra i vicoli della Città Vecchia, passando dai quartieri arabi
a quelli ebraici senza riuscire ad afferrare la sua essenza. Quella era
Gerusalemme, un mistero che da millenni cercavano di sciogliere nelle
sue madrase, nelle scuole di Torà, nelle sue chiese.
Infilarmi in quella situazione caotica e confusa non mi pareva una buona
soluzione, e dopo qualche pranzo a base di kebab e felafel, ho ripreso
un aereo per Roma, confuso fra i pellegrini di ritorno dal Santo Sepolcro.
Appena sbarcato in Italia sono caduto in depressione.
“Dove avrei potuto combattere? Con chi?” mi chiedevo svuotando
una bottiglia dopo l’altra di birra tiepida in una camera d’albergo
affacciata sulla stazione Termini. Migliaia di persone passavano sotto
di me e ognuna sembrava avere chiaro in mente dove andare. Soltanto qualche
barbone bighellonava senza apparente meta per i marciapiedi del piazzale.
Io sapevo bene quello che volevo fare, ma non avevo ancora deciso dove.
Mi sedetti sul letto e per un istante chiusi gli occhi. Il soffitto chiazzato
di umidità, nella penombra della sera, lasciò il posto alle
luci al neon di una stanza intonacata di fresco.
(...)
Nato
nel 1978 Milano, Federico Riccardo Chendi si è laureato
in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Modena
e Reggio Emilia con una tesi in Storia del Giornalismo sulla strage di
Piazza Fontana nella stampa Italiana: “12 dicembre 1969: la strage
di (…) come oggetto e come rappresentazione.” Dopo la laurea,
rientrato a Milano, per un anno sostiene di aver fatto l’editor presso
la Rizzoli. Di seguito, ha lavorato tre anni presso una Galleria d’arte
di Firenze. Nel 2007, di nuovo a Milano, ha aperto un locale dando sfogo
alle sue passioni per gli anni ‘70. Il locale si chiama Ligera -
dedicato alla mala romantica milanese. Di fronte al locale c’è
una moschea e di fianco un ristorante cinese; dunque, in periferia di
Milano e al centro del mondo.
E’ appassionato di letteratura noir e di film poliziotteschi, in
particolare il cinema di Fernando di Leo tratto da Scerbanenco. Va in
giro anche di notte con i ray-ban a goccia, porta i baffi alla Maurizio
Merli, basette lunghe, camicie troppo strette dai colori improbabili.
Guida tutti i giorni - alla faccia dell’ecopass - un’Alfa Romeo
GT Junior del 1974, come quella che avevano Pasolini e Vallanzasca. Di
se stesso dice: “Non sono un nostalgico, semplicemente gli anni ‘70
per me sono appena cominciati.”
Nel 2008 ha pubblicato la raccolta di racconti Volevo essere Vallanzasca (Cicorivolta).
Questo è il suo primo romanzo.